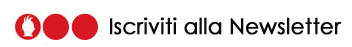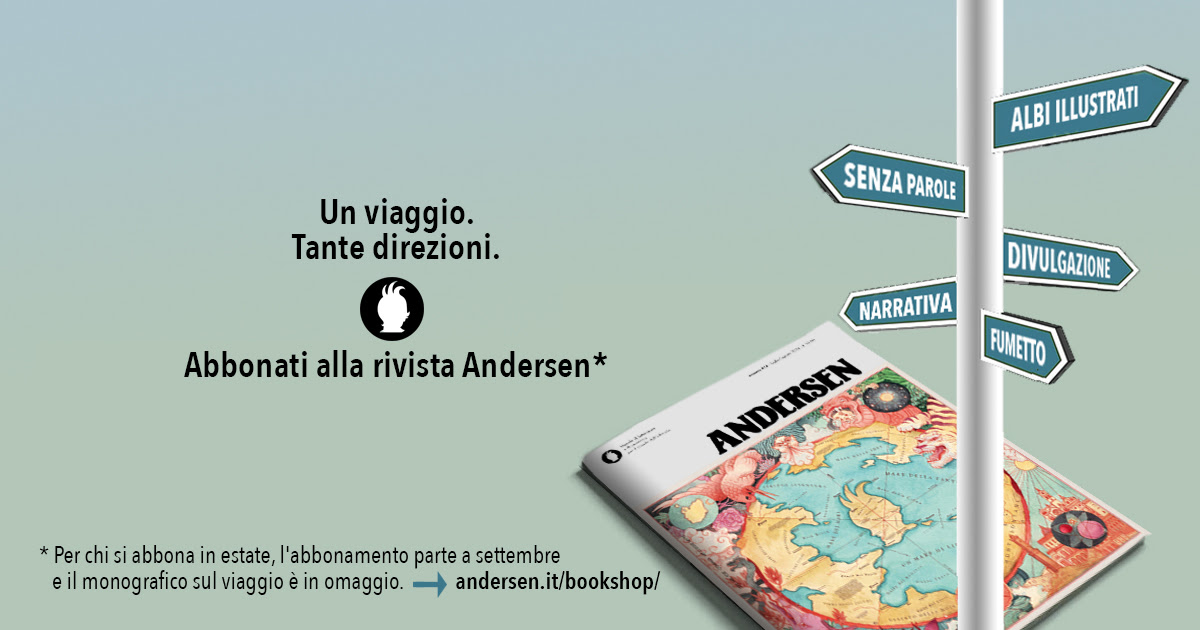Per rendere omaggio a Marina Colasanti (1937-2025), condividiamo oggi dal nostro archivio l’intervista a cura di Anselmo Roveda pubblicata su Andersen n.358 nel dicembre del 2018.
Marina Colasanti è una delle più apprezzate scrittrici brasiliane per l’infanzia, ma non solo per l’infanzia. Già, perché il suo mestiere è raccontare, rappresentare e emozionare per parole, a trecentosessanta gradi; e così – in consonanza con quell’idea di “autore totale” più volte sottolineata anche qui (n. 311, aprile 2014, “Andersen”) da Maria Teresa Andruetto (di cui, tra l’altro, Colasanti è traduttrice in Brasile), e valida pure per, limitandosi a noti nomi italiani, Bianca Pitzorno, Roberto Piumini, Giusi Quarenghi o Angela Nanetti – nell’opera di Marina Colasanti trovano posto giornalismo, narrativa per grandi, poesia, traduzioni.
In Brasile il suo nome sta accanto a quello dei grandi della letteratura per ragazzi – Monteiro Lobato, Lygia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, Ziraldo… – e la sua opera ha meritato più volte il Premio Jabuti e l’inserimento nelle raccomandazioni di lettura dellla FNLJ (Fundação Nacional do Livro. Infantil e Juvenil), sezione brasiliana dell’IBBY; tra i tanti riconoscimenti anche i recenti Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Juvenil e Premio Cátedra Unesco de Leitura PUC-RJ. Autrice di punta della letteratura lusofona per l’infanzia, i suoi libri conoscono ampia diffusione anche nel mondo ispanofono grazie alle numerose edizioni in castigliano e qualche altra sortita in Europa con, più rare, traduzioni in inglese, tedesco e francese.
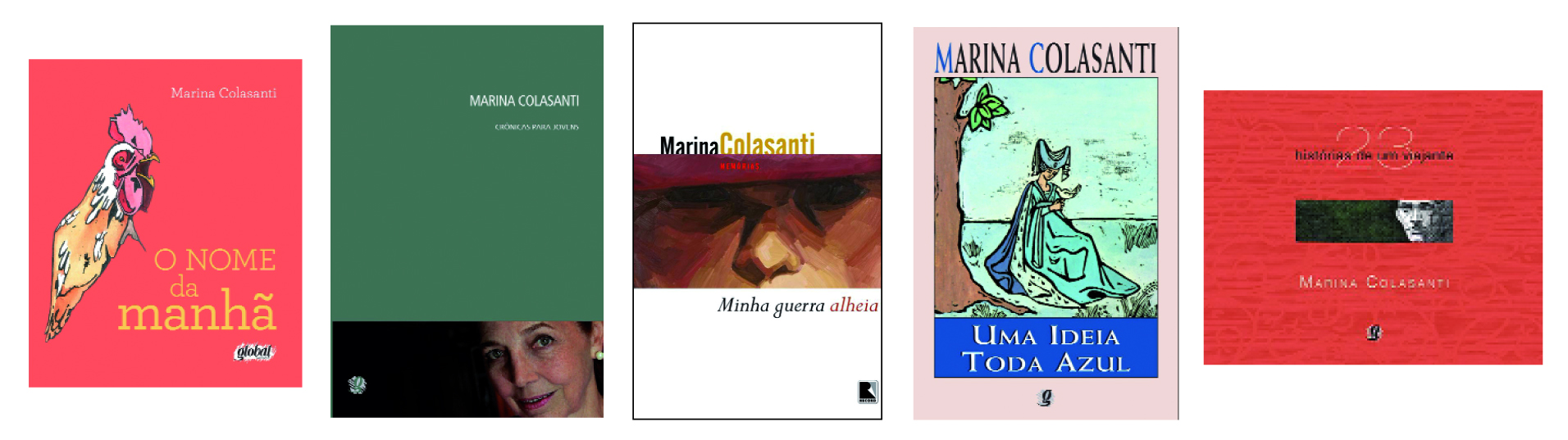
In Italia – ad eccezione del racconto La mano in pasta compreso in 4 storie di dolci (collana “Tuttestorie”, Mondadori, 1993), a cura di Francesca Lazzarato, e ad alcun testi poetici in rete – è però pressoché inedita. Eppure… nome e cognome potrebbero metterci su giusta pista… Marina Colasanti è italiana, un’italiana arrivata in Brasile a undici anni. Quindi ad avvenuta piena maturazione linguistica. Ma nel portoghese brasiliano ha trovato presto casa, e lingua prediletta per l’espressione scritta, dedicandosi – dopo gli studi in Belle Arti – prima al giornalismo e, poi, alla letteratura. Oltre una cinquantina di apprezzati titoli in proprio (Eu sozinha, Um amigo para sempre, Uma Idéia Toda Azul, Passageira em Trânsito, Como uma carta de amor, O Nome da Manhã, … ) e una serie di traduzioni importanti; da diverse lingue, innanzitutto l’italiano. Alberto Moravia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Fulvio Tomizza, Carlo Collodi tra gli autori tradotti, con la versione di Pinocchio capace di meritarsi l’inclusione nella IBBY Honour List 2004. Un’autrice brasiliana con salde radici italiane. Fatto non raro nella letteratura di quel paese, soprattutto tra discendenti di emigranti (Dalton Trevisan, Domigos Pellegrini, Diogo Mainardi…), ma anche, come per Colasanti, con arrivi durante l’infanzia; è il caso di un’altra autrice per bambini: Eva Funari, nata a Roma nel 1948 e trasferitasi con la famiglia, a soli due anni, in Brasile.
Il viaggio d’infanzia di Marina Colasanti però è diverso, più tortuoso, più avventuroso. Nasce ad Asmara, principale città della colonia Eritrea, nel 1937; ma la famiglia si trasferisce prestissimo in Libia, altra colonia allora italiana, e poi nel 1940, iniziata la seconda guerra mondiale, ripara in Italia dove la guerra e la confusione del tempo le fanno vivere un’infanzia che l’autrice ha rievocato come popolata più da libri che da compagni di giochi. Poi l’arrivo in Brasile per un intreccio familiare da romanzo. Forse, oggi, potremmo dire che quelle letture d’infanzia sono state una fortuna… l’inizio di un percorso.
Ci racconta delle sua infanzia? Come è arrivata in Brasile? Che posto hanno avuto i libri per lei durante quel periodo, fino agli 11 anni? Quali le letture e gli autori amati?
La mia infanzia l’ho raccontata nel libro Minha Guerra Alheia. È stata soprattutto un infanzia nomade, da Asmara a Tripoli, da Tripoli a Roma. E poi, nei cinque anni di guerra, andando in su, a tappe, fino a Como e cambiando casa, città, scuola. Ho imparato a non esigere, non chiedere, essere sempre estranea, e a guardare attentamente il nuovo per poterlo assimilare.
Mi hanno, più che aiutata direi formata, i libri. E quando dico libri mi riferisco soprattutto a Salgari, e alla collezione “La Scala d’Oro” che mi illudo di aver letta tutta. Non avendo amicizie, non potendo portare giocattoli nei traslochi, ad ogni nuova città i miei genitori compravano libri, che io e mio fratello divoravamo in tandem. Gli autori più amati furono Omero, Cervantes, Dumas, Poe, Defoe, Swift adattati per ragazzi e indimenticabili, e Salgari, Kipling, Verne. Quando sono arrivata in Brasile ero pronta. Ci siamo andati perché, finito il sogno africano e con l’Italia in dopoguerra mio padre ha pensato a quella parte della sua famiglia che viveva a Rio. Sua zia era la grandissima mezzo soprano Gabriella Besanzoni, sposata a un armatore brasiliano, e mio padre già conosceva il Brasile.
Come è stato l’incontro con un’altra lingua, già da preadolescente? Come l’ha imparata, quando ha iniziato scriverla e quando ha deciso di farne lingua d’espressione letteraria?
L’incontro è stato facile, assente qualsiasi trauma linguistico. Nella villa della zia dove siamo andati ad abitare inizialmente – oggi è una scuola d’arte di proprietà del governo – tutti parlavano anche italiano. Ci fu uno zio che ci leggeva le storie a fumetti facendo la traduzione. E subito fu contrattato un maestro per insegnarci il portoghese. Il mio ricordo è di scivolare senza sforzo da una lingua all’altra. E poi andammo a una scuola regolare, non alla Dante Alighieri.
Come professionista ho cominciato a scriverla quando sono diventata giornalista, ma una delle ragioni per le quali sono stata assunta – senza nessuna esperienza previa- era appunto perché scrivevo bene. Poi subito mi diedero una rubrica, quello che in Brasile di chiama “crônica” (n.d.r.: una prosa giornalistica molto apprezzata in Brasile nella quale, partendo da fatti, l’autore si rivolge al lettore con tono informale e diretto, ampliando la riflessione anche con elementi di tenore narrativo), e l’accoglienza dei lettori mi diede fiducia per scrivere il primo libro.
Come è avvenuto l’incontro, come autrice, con la letteratura per l’infanzia? Quando e perché ha iniziato a scrivere per bambini?
Una casualità. Erano i tempi della dittatura militare in Brasile, e l’editrice del supplemento infantile, coinvolta nella resistenza, fu portata in prigione. Il caporedattore del giornale mi chiese di sostituirla, e per una questione etica decisi di mantenere l’ordine e i collaboratori scelti da lei, affinché, al ritorno, trovasse la casa come l’aveva lasciata. Però, editare con mano altrui non è facile. E finì che un giorno mi ritrovai con uno spazio vuoto senza aver niente da metterci. Spavalda, pensai che potevo “smontare” una favola ben nota e chiedere ai piccoli lettori di “rimontarla”. Avrei fatto io stessa l’illustrazione. Ma quando mi misi a scrivere pensando alla Bella Addormentata, mi venne fuori una favola diversa, una favola nuova che mi sorprese enormemente. Ero entrata nella caverna di Ali Babá, nel sacro regno delle favole. E seppi immediatamente che era il posto per me. Purtroppo c’ero entrata per caso, senza il lasciapassare, e mi toccò poi faticare per trovarlo.
Quali ritiene essere le peculiarità di un testo che avrà come lettori, prevalentemente, bambini e ragazzi?
Ognuno fa le sue scelte. La mia è stata fin dal principio l’indipendenza abbinata alla qualità. Per indipendenza intendo non essere a servizio di principi didattici o morali, non usare il racconto come un cavallo di Troia per trasportare nella città dell’infanzia idee che, valide oggi, magari cambieranno domani. Per qualità intendo la qualità letteraria, il potere costruttivo del linguaggio simbolico, della metafora.
Non cerco di imitare i bambini o i ragazzi, non tento di parlare o pensare come loro, non mi sforzo per dargli quello che attendono. Mi sembrerebbe una falsificazione. Scrivo come l’adulta che sono, fidandomi della loro infinita capacità di assimilazione e cosciente dei loro timori.
Oltre ai libri per bambini e ragazzi, scrive prosa giornalistica, narrativa e poesia. Come e quando capisce che una certa un’idea può diventare giusta per una delle diverse forme letterarie che usa?
Nonostante la poesia e il giornalismo siano attività sempre parallele – il giornalismo come mestiere e la poesia per necessità interna – non scrivo oggi una cosa e domani un’altra. Ogni libro è un progetto chiuso che guida sguardo e ricerche. Non ho idee aleatorie, le idee sorgono motivate e a servizio del libro in cui sono coinvolta. Per esempio, se sono impegnata in un libro di poesia per bambini, non c’è caso che me ne venga una adulta. E le favole non sorgono mai senza aprire l’inconscio.
A fianco dei libri come autrice ha prestato la sua lingua anche alle traduzioni di grandi autori, italiani e non solo, da classici come Collodi a contemporanei come Andruetto. Qual è per lei il lavoro letterario che deve o può compiere un traduttore-scrittore sull’opera di un altro scrittore?
Mi impegno intensamente nella fedeltà. E concepisco la fedeltà non solo nel rispetto alla scelta di ogni parola, ma nella trasposizione del ritmo e della bellezza melodica che l’autore ha impresso al testo originale. Sbagliare una parola può succedere a chiunque, ma un buon traduttore non può permettersi di “appiattire”, di ridurre, nella sua lingua, il testo che ha ricevuto. Quando sto traducendo non riesco a scrivere per me, sono troppo impregnata di un altro suono. Tradurre è come ricevere una trasfusione. Avendo già vissuto l’esperienza opposta so quanto sia sgradevole quando il traduttore traduce la lingua ma non rispetta lo stile. Come scrittrice sono molto condensata, getto a mare tutta la zavorra linguistica. Ma assai spesso, quando mi traducono, ripescano tutto quello che ho buttato via e magari ci aggiungono anche qualche ghirigoro!
Un accenno alla traduzione di Andruetto. Lei ha tradotto la mia poesia, io ho tradotto quattro dei suoi libri, e fare la spola tra il testo di una e quello dell’altra ci ha dato un affiatamento tale che ora ricevendo da lei un libro in lingua originale lo leggo quasi tradotto.
Scrittrice brasiliana apprezzatissima internazionalmente, purtroppo poco pubblicata in Italia. Quali suoi libri consiglierebbe all’editoria italiana, quali vorrebbe che fossero disponibili al lettore italiano?
Avrei amato vedere in italiano Minha Guerra Alheia (La mia guerra altrui), che è stato pubblicato in Germania. Ma capisco che, con tanti libri sulla guerra, possa sembrare soltanto uno in più. Le mie favole però non sono mai “in più”. Qualsiasi libro sarebbe consigliabile ai lettori italiani. Il primo, Uma Idéia Toda Azul (Un’idea tutta blu) che ha vinto un sacco di premi, già pubblicato in spagnolo e in inglese. Oppure Longe Como o Meu Querer (Distante come il mio desiderio) riconosciuto in Colombia con il premio NormaFundalectura. O anche 23 Histórias de Um Viajante (23 storie di un viaggiatore) un libro che riprende il modello classico, in cornice. La scelta non è difficile, ho scritto piú di cento favole, e sono tutte belle.
Ancora a proposito di Italia e lingua: qual è il suo rapporto con l’italiano? Con chi e quando lo utilizza? Lo utilizza per la creazione letteraria?
Ho conservato l’italiano come tesoro personale. È la mia lingua d’anima. Penso sia in italiano che in portoghese, ma il mio diario lo scrivo solo in italiano. Non lo parlo quasi mai però, solo quando vado in Italia, e ci vado assai raramente. Non ho amici italiani. Lo parlo con me stessa, e lo scrivo spesso nella corrispondenza di profonda amicizia stabilita con la mia traduttrice in USA, Adria Frizzi. Molto spesso le idee letterarie le appunto in italiano, ma per la creazione letteraria non oso, so che il mio italiano è invecchiato, gli manca freschezza, sprint. E spesso commetto sbagli. Mi sono tradotta solo una volta, per quell’edizione Mondadori (n.d.r.: La mano in pasta; in: 4 storie di dolci, 1993). Ma poi ho sottomesso la traduzione a criteri più severi.
Concludendo: è nata da genitori italiani in Africa, dove ha vissuto la primissima infanzia, poi ha passato qualche tempo in Italia, quindi è arrivata in Brasile che è diventato casa; nel percorso le molte lingue degli incontri e del lavoro. Una cosmopolita, a tutti gli effetti. Cos’è allora per lei l’identità? Quanto ha a che fare con la lingua? Che relazione c’è tra particolare (valorizzazione delle diverse tradizione culturali e linguistiche) e universale (conoscenza dell’altro e accesso al mondo)?
Non so come sia un identità unica. Non ho questa esperienza. Spesso mi domando come si sente uno che è nato in una città o un paese e ci è sempre rimasto. Uno che ha sempre inteso un’unica lingua. La mia identità si sdoppia in tre , o si “stripla”: essere nata in Africa – unica africana della mia famiglia – ha fatto di me sin dall’inizio una differente; sono senza alcun dubbio una scrittrice brasiliana, sia per la lingua che mi va come una pelle, sia perché rappresento il Brasile all’estero; ma sono una persona italiana. Per me, fino ad oggi, a Natale nevica e la primavera è in aprile – debbo stare attenta quando scrivo; l’architettura della mia immaginazione è piena di colonne, capitelli e archi; faccio la pasta per il piacere di impastare e di aspirare l’odore della farina in trasformazione; ho costante bisogno di arte e di armonia; e non ho mai avuto una casa senza gerani.
Una parte della mia identità è ancorata nel particolare, ma il resto è fatto di mondo.